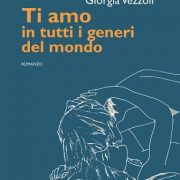Importa davvero conoscere il genere di una persona per amarla?
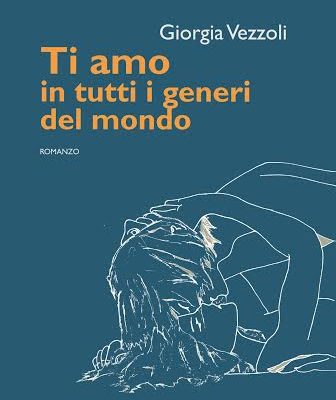 A Nina importa davvero sapere se Sasha è maschio o femmina o le basta quel sentimento che sente crescere?
A Nina importa davvero sapere se Sasha è maschio o femmina o le basta quel sentimento che sente crescere?
Poche pagine e te lo chiedi anche tu, lettore, insieme alla protagonista dell’ultimo libro di Giorgia Vezzoli, Ti amo in tutti i generi del mondo, Edizioni Giraldi.
Quello di Giorgia è un romanzo che lentamente ti conduce in una storia in cui, novità editoriale assoluta, uno dei protagonisti è di genere non definibile. Continua a leggere