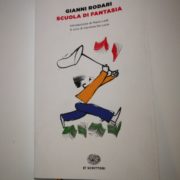Sapersi ascoltare, sapere parlare: due regole di Gianni Rodari valide anche online

La discussione e la dialettica online sono diventate sempre più difficili? La prevaricazione, lo sdegno e il giudizio sono le caratteristiche prevalenti del dibattito in rete? L’ascolto dell’altro è faticoso e ci si allena sempre meno a praticarlo?
Tanti spunti – per sviluppare anticorpi a tutto ciò e praticare una relazione generativa con gli altri online – li troviamo fuori dalla rete. Perché alla fine, è chiaro, le dinamiche sociali sono sempre quelle e prima che un’educazione digitale, abbiamo bisogno di tornare a un’educazione relazionale che sta alla base di tutto quello che facciamo in mezzo alle persone.
Nella raccolta di saggi di Gianni Rodari, Scuola di fantasia (Einaudi, 2014) lo scritto “Bambini, insegnanti, genitori” del 1970 contiene due consigli che dovrebbero essere una stella polare anche per chi usa i social network.
Ci sono regole non scritte, non codificate, che tutti dobbiamo, insieme, fare nostre. La prima è sapersi ascoltare. Abbiamo sempre troppa fretta di scavalcare le persone per arrivare allo schema che le rappresenta. Chi è quello che parla? Un reazionario. Un estremista. Un esibizionista. Un democristiano. Un liberale. Un idealista. Eccetera. L’etichetta ci serve per anticipare le sue conclusioni, per schematizzare il suo discorso. E così ci vietiamo di capire se in ciò che sta dicendo c’è, o non c’è in modo indiretto e distorto, qualcosa che può essere vero e utile per noi.
Un’altra regola è quella di saper parlare. Parlare di cose, di problemi, di oggetti, senza personalismi, senza esibizionismi. Parlare per dire, non per ascoltarsi. Parlare per comunicare, non per sfogarsi. Parlare per cercare, non per auto-affermarsi, non per proclamare. Più difficile, ma ugualmente necessario, è nell’incontro e nella discussione non cercare la vittoria, ma l’intesa, la decisione possibile e opportuna. Discutere per avere assolutamente e sempre ragione su ogni punto è puerile.